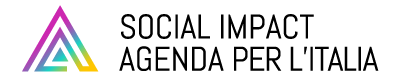di Laura Cosa, Project Manager Torino Social Impact
Quando si parla di finanza a impatto, spesso si scivola nel rischio del “greenwashing o socialwashing”: tante belle parole e poi nella pratica poca sostanza. E invece no. La finanza a impatto – quella vera – è una cosa molto seria, perché ha l’ambizione (e la responsabilità) di rimettere in discussione il modo in cui i soldi si muovono nell’economia per generare non solo profitto, ma anche valore sociale e ambientale.
Torino Social Impact, un’alleanza territoriale ed ecosistema in continua evoluzione che riunisce oltre 350 attori tra imprese, istituzioni pubbliche e private, profit e non profit per rafforzare il sistema locale e qualificarlo come uno dei migliori posti al mondo per fare impresa e finanza di impatto, da questo punto di vista, è uno dei laboratori attivi che più contribuisce al tema in Italia. Non solo per la sua visione, ma per il tentativo concreto di mettere in campo strumenti reali. Due su tutti: la Borsa dell’Impatto Sociale e l’Outcome Fund Platform.
Innovazione sociale come campo di investimento strutturato
Partiamo da una domanda scomoda: serve davvero la finanza ad impatto? Se pensiamo che il sistema finanziario sia ormai scollegato dalla realtà quotidiana di comunità, territori e bisogni sociali, allora sì, serve eccome. E serve anche il coraggio di costruire ponti tra mondi che spesso non si parlano: quello degli investitori istituzionali e quello delle cooperative sociali, delle startup a vocazione sociale, dei servizi pubblici che tentano di innovarsi.
Ecco dove il masterplan (o piano strategico) di Torino Social Impact mostra la sua ambizione: creare un ecosistema in cui l’innovazione sociale non sia solo un tema da convegni, ma un campo di investimento strutturato.
Il masterplan di Torino Social Impact non è (solo) una bella cornice strategica: è un tentativo concreto di costruire un’infrastruttura a supporto dell’economia sociale e dell’innovazione d’impatto, con l’ambizione di farlo in modo sistemico.
In questo contesto, la finanza a impatto non è un accessorio, ma una leva fondamentale. Perché? Perché uno dei grandi problemi dell’economia sociale è l’accesso al capitale. Le imprese sociali, le cooperative, le startup a vocazione sociale e le organizzazioni non profit hanno spesso difficoltà a ottenere finanziamenti nei circuiti tradizionali. Percepite come “rischiose”, “poco scalabili”, o semplicemente “non bancabili”, rimangono intrappolate in un sottobosco di micro-finanziamenti, bandi a pioggia o donazioni poco strutturate. Il masterplan propone invece un’altra strada: mettere in moto capitali pazienti, intelligenti, orientati al lungo periodo, capaci di sostenere progetti che generano valore economico e impatto sociale. Non si tratta solo di “fare beneficenza con metodo”, ma di integrare la logica di rendimento con quella di trasformazione. In altre parole: far sì che chi investe in progetti sociali non lo faccia solo per “sentirsi buono”, ma perché quei progetti hanno senso, solidità, visione.
La finanza a impatto, dentro il masterplan, diventa così una colonna portante del sistema: non solo perché fornisce soldi, ma perché costruisce condizioni di fiducia, trasparenza e misurabilità, aiutando l’economia sociale a emanciparsi dalla precarietà cronica e a crescere in modo strutturato. Ed è in questo quadro che strumenti come la Borsa dell’Impatto Sociale e l’Outcome Fund assumono un valore strategico. Non sono solo “strumenti tecnici”, ma mattoni di una nuova architettura economica, che prova a ridisegnare le regole del gioco.
Borsa dell’Impatto Sociale: un mercato secondario per far crescere l’economia
sociale
Tra i progetti più ambiziosi del piano strategico di Torino Social Impact c’è sicuramente la Borsa dell’Impatto Sociale, un’iniziativa che punta a creare un canale addizionale di finanziamento per l’economia sociale. L’idea è tanto semplice quanto rivoluzionaria: costruire un mercato finanziario dedicato alle imprese a impatto in cui gli investimenti a impatto – una volta attivati – possano essere scambiati, valorizzati, resi liquidi.
Tradotto: oggi chi investe in un progetto sociale spesso si trova “bloccato” per anni, senza possibilità di uscita o di riallocare capitale. Questo frena molti investitori potenziali. La Borsa dell’Impatto prova a superare questo limite, offrendo visibilità e circolazione agli strumenti finanziari legati all’impatto.
Non solo: questo progetto ha anche una funzione culturale e sistemica. Costruire un mercato dell’impatto significa dare dignità economica a un settore spesso trattato come marginale, e allo stesso tempo stimolare la standardizzazione dei dati, la trasparenza, la valutazione rigorosa.
In pratica, aiuta a rendere l’impatto “leggibile” anche per chi arriva dal mondo finanziario più tradizionale. Naturalmente, come ogni mercato, anche questo va progettato con cura: non basta mettere in vetrina progetti sociali, bisogna garantire qualità, verificabilità degli impatti, e soprattutto evitare che l’intermediazione svuoti di senso il valore trasformativo dei progetti. Ma se gestita con intelligenza, la Borsa dell’Impatto può diventare un’infrastruttura chiave per far crescere e consolidare l’economia sociale nel lungo periodo.
Uno degli aspetti più innovativi del progetto della Borsa dell’Impatto Sociale è l’intento di costituire un fondo di liquidità a supporto del mercato nascente. In un contesto dove gli strumenti ad impatto sono ancora poco liquidi e scarsamente scambiati, questo fondo ha un ruolo cruciale: garantire stabilità, incentivare la partecipazione e ridurre il rischio percepito dagli investitori, soprattutto quelli che si affacciano per la prima volta a questo mondo.
Il fondo funzionerebbe come una sorta di “acquirente di ultima istanza”, capace di acquistare o rilevare quote di strumenti finanziari sociali qualora il mercato secondario non fosse in grado di assorbirle in tempi utili. In questo modo si crea un cuscinetto di fiducia che permette agli investitori di impegnarsi con maggiore serenità, sapendo di avere un’eventuale via d’uscita, e allo stesso tempo si aumenta la credibilità e l’attrattività dell’intero ecosistema.
Naturalmente, per evitare che diventi un meccanismo di “paracadute” passivo, è fondamentale definire regole chiare di accesso e criteri di selezione rigorosi, legati alla qualità dei progetti e alla misurabilità dell’impatto. Ma se ben progettato, questo fondo potrebbe essere la chiave per sbloccare una nuova fase di maturazione del mercato dell’impatto, creando le condizioni per attrarre capitali pazienti, ma anche più istituzionali.
Outcome Fund: pubblico e privato insieme per affrontare le sfide sociali più complesse
Anche l’Outcome Fund è un altro strumento chiave del masterplan: un meccanismo di contratti outcome based che remunera gli attori sociali solo al raggiungimento di determinati esiti (outcomes), misurati e verificabili.
È un’innovazione importante perché sposta il focus dalla prestazione all’effetto generato. L’Outcome Fund rappresenta un tentativo concreto di riprogettare il modo in cui si finanziano le politiche sociali. La logica è semplice ma potente: invece di finanziare l’erogazione di un servizio, si finanziano i risultati.
Ma il valore vero dell’Outcome Fund sta nella sua capacità di attivare una collaborazione strutturata tra attori pubblici e privati. Le sfide sociali più complesse non si risolvono con strumenti lineari, ma richiedono interventi multipli, coordinati, personalizzati. E questo può avvenire solo se si riesce a coinvolgere una pluralità di soggetti (pubblica amministrazione, attori filantropici, investitori a impatto, service provider e valutatori indipendenti), in grado di intervenire con strumenti differenziati e tempistiche di lungo termine.
In questo schema, i provider sociali non sono più meri esecutori, ma soggetti attivi che progettano strategie d’intervento, assumono rischi, innovano pratiche. Hanno spazio per sperimentare soluzioni diverse, adattarsi ai bisogni reali delle persone, agire in maniera più efficace e flessibile rispetto ai tradizionali vincoli della rendicontazione a prescindere dai risultati.
Per far funzionare questo meccanismo, servono però alcune condizioni: un sistema di misurazione dell’impatto robusto e condiviso, un’attenta selezione dei target di outcome, e soprattutto la volontà – da parte del settore pubblico – di investire nel cambiamento anziché solo nella gestione dell’esistente. Non si tratta solo di pagare a risultati: si tratta di co-produrre valore sociale in modo intelligente, condividendo rischi e responsabilità. Quando l’erogazione delle risorse avviene a fronte del raggiungimento del risultato, si rischia di finanziare solo ciò che è “facile da misurare” o “probabile da raggiungere”, lasciando fuori esperienze più sperimentali, più fragili, ma magari più trasformative nel lungo periodo. Il rischio è quello del cherry picking: scegliere solo beneficiari “facili”, progetti “a basso rischio”, impatti “di superficie”. Serve invece una strategia mista, che includa una quota di capitale paziente, capace di accettare l’incertezza e la complessità dei cambiamenti sociali veri e preveda premialità per le diverse categorie di beneficiari.
L’Outcome Fund, se ben calibrato, può diventare una leva potente per catalizzare innovazione sociale e mobilitare capitali privati su obiettivi pubblici.
Un esempio concreto di come l’Outcome Fund possa trasformarsi da teoria a pratica è rappresentato dal progetto finanziato dalla Commissione Europea TOUCH – Tackling outcome- based finance challenges: a replication model for social economy, un progetto europeo che sta lavorando proprio alla creazione di un meccanismo di outcome-based funding in Piemonte, focalizzato sul problema dei NEET, ovvero giovani fuori da percorsi di istruzione, formazione e lavoro, con vulnerabilità aggiuntive. Questo progetto rappresenta un banco di prova importante per testare la fattibilità tecnica, politica e operativa di un Outcome Fund in Italia, con uno sguardo europeo. Ed è anche un’occasione preziosa per imparare, condividere errori e successi, e costruire un modello scalabile e replicabile in altri territori e su altre problematiche.
Il futuro: contaminare, contaminarsi, sbagliare insieme
Torino Social Impact sta dimostrando che un’altra finanza è possibile: serve cambiare le regole del gioco, i rapporti tra gli attori, la cultura del rischio e del valore. La finanza ad impatto, per funzionare davvero, ha bisogno di relazioni stabili, trasparenza nei processi, e una visione condivisa degli obiettivi sociali da perseguire. Strumenti come la Borsa dell’Impatto Sociale e l’Outcome Fund sono rilevanti in quanto occasioni di apprendimento collettivo, sperimentazione e costruzione di nuove alleanze. E vanno trattati come tali: con serietà, ma anche con spirito critico. La sfida successiva è far sì che queste esperienze non rimangano buone pratiche isolate, ma processi replicabili, aperti alla contaminazione, per far diventare la finanza uno strumento di trasformazione sociale.
Laura Cosa
È consulente per i progetti dell’area Finanza di Torino Social Impact e Project Manager del progetto Borsa di Impatto Sociale. Dopo la laurea in Finanza, ha lavorato per una ONG internazionale specializzata in progetti di microcredito e cooperazione internazionale. È co-fondatrice di Impact Hub Torino, una filiale di una comunità globale di imprenditori sociali, di cui è stata CEO dal 2016 al 2020. Collabora come consulente anche per l’area impact investing di Human Foundation.
𝐒𝐈𝐀 𝟐𝟎𝟑𝟎 è il 𝐛𝐥𝐨𝐠 di Social Impact Agenda per l’Italia sulla 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐚 𝐈𝐦𝐩𝐚𝐭𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐠𝐥𝐢 𝐒𝐃𝐆𝐬.
Pensieri, analisi e proposte per una nuova finanza a beneficio delle persone, delle comunità e del pianeta.
Iscriviti alla Newsletter SIA e ricevi gli aggiornamenti dall’ecosistema dell’impact investing italiano e internazionale.
Eventi, novità e opportunità dal mondo della finanza a impatto, insieme agli approfondimenti dal nostro blog, periodicamente, nella tua casella di posta.